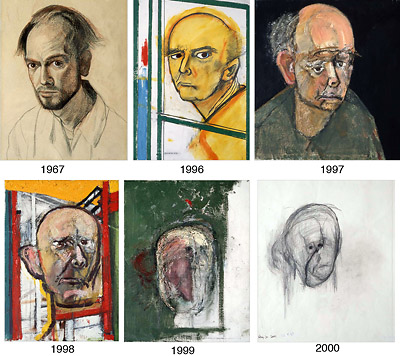Caro professore,
Tutti quanti nasciamo con l’idea di voler vivere una
vita che non sia mai monotona, di poter fare per sempre ciò che realmente ci
appassiona. Nasciamo col desiderio di poter cambiare le cose, cambiarle in
meglio. Fin da piccoli ci abituiamo a coltivare un sogno che spesso sembra poco
probabile o molto difficile da realizzare. Crescendo ci lasciamo trasportare da
infinite variabili esterne che ci fanno perdere la voglia di crederci fino in
fondo. «Tanto ci riesce una persona su un milione», «figurati
se fila tutto liscio»; la nostra testa si riempie di dubbi, basta poi
qualcuno che aggiunga ulteriore diffidenza ed ecco che tutto rischia di
crollare. Se davvero dobbiamo raggiungere un obiettivo non dovremmo mai
ascoltare queste voci. Ho visto tanti sognatori restare tali senza capire che
sognare non basta più. A me sognare non potrà mai più bastare. Quello che
voglio fare è realizzare. Si sa, se si vogliono raggiungere cose che agli occhi
di tutti sono difficili, bisogna essere disposti a dare tutto senza fermarsi, e
crederci sempre. Noi giovani spesso cominciamo qualcosa e dopo poco tempo
lasciamo perdere. Tutto questo perché non sempre siamo in grado di motivarci,
non sempre capiamo che è necessario fare dei sacrifici e fare cose che gli
altri non sarebbero disposti a fare. Perché non si è più disposti ad inseguire
un obiettivo, un sogno, fino alla fine? Insomma, essere disposti a pagare il
prezzo che ogni desiderio possiede?Chiara, 3F
Cara Chiara,
La tua lettera è piena di forza e di concretezza: «Sognare
non basta più», «A me sognare non potrà mai più bastare». Dici bene:
lo sguardo fluttuante, la discontinuità della direzione, gli inevitabili dubbi,
il sospetto – anche in buona fede – che proviene dalle persone care, la
casualità degli eventi rendono incerti i progetti più arditi o più personali.
Confidare nelle proprie idee è pertanto indispensabile, ma per realizzare i
propositi è essenziale una forza che gli antichi chiamavano perseveranza. Per
dar vita ad un sogno non è sufficiente richiamare l’attenzione su di sé o su un
ipotetico progetto incantatore. Seneca, ad esempio, avvertiva Lucilio di stare
attento e di evitare coloro «desiderano non progredire, ma farsi notare». Alcune
persone sono incapaci di gestire la propria rotta e sono piuttosto trascinate
inavvertitamente dalla corrente. Scrive il filosofo: «Pochi sono
quelli che regolano se stessi e le proprie azioni secondo un progetto: gli
altri, come le cose che galleggiano sui fiumi, non avanzano, ma vengono trasportati; fra questi, alcuni sono
trattenuti da un’onda più leggera e spostati con più dolcezza, altri
sono trascinati da una più violenta, altri sono deposti vicino alla riva da una
corrente che si illanguidisce, altri sono gettati in mare dall’impeto delle
acque. Perciò, dobbiamo determinare che cosa vogliamo, e perseverare in tale
proposito» (Lettera 23, 8). «Determinare cosa vogliamo» e «perseverare»
significa che è necessario non solo chiarire a se stessi un obiettivo, ma
confermarlo nel tempo; rimanere fedeli a un proposito che si è originato da una
passione o da una motivazione intima, senza eccessivi indugi, coscienti che la
dedizione implica necessarie rinunce. Seneca sosteneva che la differenza tra il
proprio lavoro e quello di altri uomini non consisteva nelle sue presunte
maggiori abilità, ma nella disponibilità a lavorare con continuità alla propria
opera; considerava dunque la regolarità nell’attività ordinaria come il proprio
vantaggio. Quando, considerando la propria vita, valuta se, nonostante tutte le
difficoltà, la strada della perseveranza abbia dato i suoi frutti, egli afferma
che, se potesse ricominciare una nuova infanzia, impiegherebbe probabilmente
soluzioni analoghe a quelle adottate nella realtà. Per questo egli invita
spesso Lucilio ad essere forte. In
questa instancabile esortazione leggiamo dunque l’invito a non capitolare
facilmente al primo refolo di vento contrario: in fondo il perseverante
è colui che è in grado di sopportare, ossia di portare su di sé, la fatica.
Tommaso d’Aquino, nella “Summa Theologica”, insegna che chi persevera
nei propri obiettivi, ha raggiunto un buon equilibrio nel dominare le proprie
azioni e afferma che i vizi che si oppongono alla perseveranza sono la «mollitia»
e la «pertinacia». Come un materiale molle cede facilmente al tatto,
l’uomo molle è colui che non riesce a resistere a nulla: una leggera pressione
o una minima difficoltà sconvolgono i suoi propositi. Poiché Tommaso è lungimirante
(anticipa il nostro tempo), ricorda che la «mollezza» deriva anche
dall’abitudine al piacere facile; egli scrive infatti che «quando uno è
abituato ai piaceri, difficilmente sa sopportarne la privazione». Al
contrario, l’uomo pertinace è colui che si ostina irragionevolmente a
perseverare in un’attività anche se i risultati gli sconsiglierebbero di farlo.
Quando uno agisce contro le evidenze contrarie, può sviluppare un attaccamento
eccessivo che gli può cagionare sofferenze inutili. Quindi, a patto di non
compromettere la propria salute, credo che «bisogna essere disposti a pagare
il prezzo che ogni desiderio possiede». Anche Seneca ti avrebbe dato ragione e ti avrebbe
sostenuta; egli era convinto – come te – che «gran parte del progresso consiste nel voler progredire» (Lettera
71, 36).Un caro saluto,
Alberto