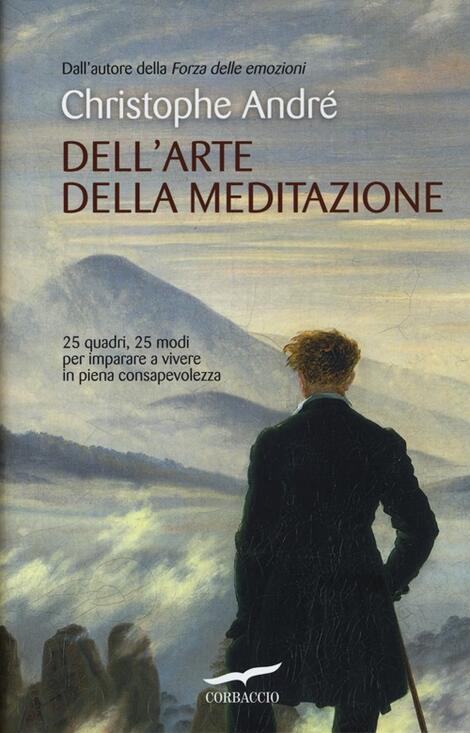Caro professore,
Da circa otto mesi non mangio più carne. Questa scelta è
maturata in me già da alcuni anni, grazie all’incontro fortunato che ho avuto
con due persone, due insegnanti che mi hanno fatto riflettere sul rapporto tra
l’uomo e il cibo, tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e gli animali e grazie ad
un bellissimo viaggio in India nel 2010 con i miei genitori. In India ho potuto
conoscere, almeno in parte, una cultura lontana dalla “nostra”, persone che pur
avendo poco, quel poco te lo offrono, ma purtroppo spesso non hanno quasi
niente. Questo viaggio mi ha fatto riflettere sulla drammatica sproporzione tra
popolazione e risorse presente non solo in India, ma in molte realtà
dell’Africa, del Sud America e in altre regioni dell’Asia. Non si tratta di una
legge malthusiana per cui la popolazione aumenta in modo geometrico e le
risorse incrementano con una progressione aritmetica, bensì di un profondo
squilibrio nell’usufruire delle risorse tra i cosiddetti Paesi sviluppati e
quelli sottosviluppati. Credo che un buon rapporto con il cibo e una misura
nella fruizione di questo sia un piccolo passo che ognuno di noi può fare per
iniziare a pareggiare i conti. Inoltre ho scelto di essere vegetariana, perché
il mio mangiare carne non era un bisogno fisiologico, non era un fatto di
sopravvivenza, dal momento che , fortunatamente, abbiamo a disposizione molti
altri generi alimentari (verdure, cereali, frutta, formaggi...), ma solo un di
più, un lusso, un piacere che mi chiedeva di far parte di un meccanismo che
reputo irrispettoso nei confronti degli animali, sia per la modalità con cui
questi animali in molti casi vengono allevati sia per la scelta di cui
consumatore divengo co-autore, di privare un essere vivente della vita, solo
per il mio personale piacere e non per presunta necessità di quella nota
“catena alimentare”. Durante il pranzo di Pasqua (ma anche in altre occasioni)
ho passato ore e ore a sentirmi dare dell’ “anormale”, a sentirmi porre domande
– perché non mangi più carne, sei diventata pazza? – , senza che gli
interlocutori fossero intenzionati ad ascoltare alcuna risposta. Ma perché
questa incapacità di molti di ascoltare punti di vista altrui e di rispettare
le scelte altrui? Perché dover sempre giudicare a priori?Federica, classe IV
Cara Federica,
Il filosofo australiano Peter Singer, uno dei primi autori
ad essersi occupato dei diritti degli animali, in “Etica pratica” [1979]
1989, riporta un curioso aneddoto riferito a Benjamin
Franklin. Alcuni suoi amici stavano per cucinare un pesce appena catturato,
quando nello stomaco del pesce ripulito venne trovato un pesce più piccolo. «Bene
— disse a se stesso Franklin — se vi mangiate a vicenda, non vedo perché non
possiamo mangiarvi noi». Singer, commentando il fatto e le successive
argomentazioni di Franklin, scrive tuttavia che «Franklin testimonia più del suo amore per il pesce fritto che delle sue capacità dialettiche». A onor
del vero, Benjamin Franklin divenne poi vegetariano e definì il mangiar carne
come «un delitto senza giustificazione» compiuto contro gli animali. In
ogni caso, la prima obiezione che viene rivolta a chi ha fatto la scelta
vegetariana consiste proprio nel fatto che la natura ha programmato l’uomo per
cibarsi di carne. Dunque, nessuno potrebbe essere accusato di scarsa
sensibilità. Tuttavia, occorre notare che nelle scelte dell’uomo interagiscono
natura e cultura. Ed è a partire dalla cultura che molte persone diventano
vegetariane, in primo luogo, perché, come te, sentono di dovere riguardo verso
le altre specie viventi e preferiscono scegliere alimenti eterogenei quando vi
siano più alternative. L’obiezione di Benjamin Franklin viene confutata da
Peter Singer, infatti egli fa notare che gli animali che si uccidono per cibo
non sarebbero in grado di sopravvivere diversamente, mentre gli uomini possono
decidere tra opzioni disponibili e riflettere sull’etica della loro dieta. Già,
proprio così, c’è anche un’«etica della dieta», e proprio qui comincia la
riflessione sul vegetarianesimo. Gli uomini possono maturare convinzioni nel
rispetto degli animali, in quanto l’empatia con gli altri esseri viventi li
muove ad una consapevolezza più ampia del valore della vita e per
le specie non umane. Ovidio, nelle “Metamorfosi”,
richiamando Pitagora, forse il primo
filosofo vegetariano, definisce: «sciagurato» l’uomo
«che scanna col ferro il vitello senza scomporsi ai suoi strazianti muggiti (XV, 465), o che ha il coraggio di
sgozzare un capretto che manda vagiti come un bambino (XV, 466). Molte persone, tuttavia,
faticano a capire. In questo caso agisce l’inerzia culturale: non si mette in
discussione la tradizione, non si considerano le sofferenze indotte dall’uomo
né i diritti degli animali. Spesso pigrizia, passività, indolenza e abitudine
impediscono di comprendere che la realtà può essere cambiata con molti vantaggi
collettivi. I tuoi parenti si comportano un po’ come la servetta di Tracia che
irride Talete che cade nel pozzo. Guardando il cielo stellato, ella vede solo
dei puntini luminosi che brillano nella notte, mentre Talete vede una realtà
ancora inaccessibile: immagina la potenza della teoria scientifica in grado di
prevedere le eclissi. La tua riflessione ci aiuta a riflettere
sull’alimentazione consapevole e credo che anticipi comportamenti collettivi
che saranno sempre più diffusi. Un caro saluto,
Alberto